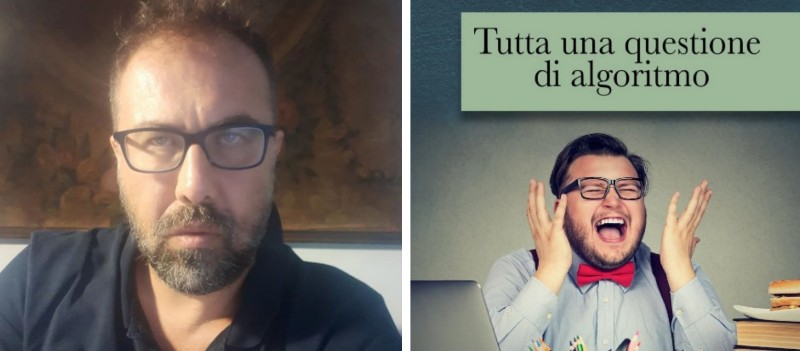“La scrittura mi è sempre parsa un’arte maieutica”. Ci spiega il suo pensiero lo scrittore Luca Bovino, da poco in libreria con il romanzo d’esordio “Tutta una questione di algoritmo”
In un anno notoriamente difficile come questo per il mercato editoriale e non solo, il panorama letterario si è arricchito di una nuova, bella penna: quella di Luca Bovino, autore del romanzo “Tutta una questione di algoritmo” (Brè Edizioni) che si è aggiudicato la Menzione Speciale al Premio Bukowski 2020, arrivando finalista nella cinquina del I concorso internazionale Montag 2020.

Luca, al tuo esordio letterario ti sei già fatto notare da premi e concorsi letterari. Quale soddisfazione hai provato? Potremmo dire “buona la prima”?
È stata un’iniezione di autostima, sempre molto gradita, specialmente per un esordiente. I premi letterari ti danno la garanzia di avere almeno un lettore: il giurato. E non è poco, se pensi che Manzoni stesso sosteneva che per ogni scrittore esistono soltanto venticinque lettori, e gli altri sono soltanto acquirenti. Però credo che i premi siano un po’ come la scala di Wittgenstein, ti servono per arrivare a raggiungere una consapevolezza di te, ma poi vanno gettati via.
Vuoi dirci qualcosa in più del tuo eroe e del suo programma… che non va propriamente come previsto?
Il mio eroe prova ad essere l’unico orbo in un mondo di ciechi, ma è sempre un orbo. Vorrebbe affidare la propria esistenza ad un programma razionale, o quanto meno ad un progetto ragionevole. E in questo consiste il suo algoritmo: vorrebbe applicare la migliore strategia possibile al proprio lavoro. Ma dimentica che ogni idea, per quanto geometrica ed esatta possa essere, resta sempre un’idea. Ed è quindi destinata a rivelarsi piccola e inadeguata rispetto all’infinita capacità di variabili che ha la natura, la vita, il mondo. Se pensi che comportandoti in un certo modo eviti un rischio, significa che non stai riflettendo su quanti altri rischi potresti correre nel frattempo, proprio cercando di evitarlo. Ecco, anche un viaggio di lavoro altrimenti banale può trasformarsi in uno scivolo verso un abisso di apocalittiche e progressive conseguenze. Però, qualcosa di inaspettato può sempre arrivare. E in effetti, nel romanzo, poi arriva.
Parole, suoni, figure retoriche: quale significato hanno per te nella comunicazione verbale e non verbale?
La comunicazione paraverbale è un tasto dolente per ogni scrittore. Come si fa a renderla? Albert Mehrabian ha dimostrato come solo il 7% della comunicazione sia affidata alle parole, cioè alla comunicazione verbale. Il 38% ai contenuti paraverbali (tono, timbro e ritmo della voce), mentre il 55% è affidato al linguaggio non verbale (mimica, postura, gestualità facciale). Le figure retoriche cercano di abbattere quel limite del 7% affidando la parola al suo richiamo sonoro, all’evocazione musicale, alla scansione ritimica. Per far trasformare quel contenuto da verbale in paraverbale. Per questo, inconsciamente, troviamo molto più efficace un pensiero se espresso con un endecasillabo, ad esempio il titolo di un giornale. E troviamo molto più accattivante un’icona con un’allitterazione o una paranomasia (vuoi un esempio? Coca Cola). Quanto la Fiat era la marca d’auto più venduta in Europa, tutte le sue vetture di punta avevano una “erre” nel nome, perché evocava suggestivamente il rombo di un motore (Ritmo, Tempra, Croma, Bravo, Argenta, Regata). Viceversa, le utilitarie hanno spesso nomi corti, con vocali accoglienti (Uno, Punto, Lupo, Panda, Palio). Ne parlava spesso anche il linguista Giuseppe Antonelli nei suoi articoli sul Corriere della sera. Ecco, per me il suono della parola è evocazione, ma anche evasione, richiamo e fuga, dal testo e grazie al testo. Per questo nel mio libro sono presenti tante figure retoriche di suono, alessandrini ed endecasillabi nascosti, persino qualche haiku. Per avere l’illusione di poter catturare un frammento di realtà, o quantomeno di poterla trasferire al lettore. E poi perché è quasi un gioco: caccia al metro.
Trovi che la scrittura abbia un potere terapeutico? Talvolta addirittura catartico?
Nel mio caso certamente l’ha avuto. La ragione che mi ha indotto a scrivere è stata quella di liberarmi da alcune esperienze alle quali non riuscivo a dare un senso, a vicende che non sapevo come elaborare, a episodi intorno ai quali continuavo a rimuginare senza sosta. E che mi tormentavano. Invece la scrittura mi ha consentito di affrancarmi da questi mostri, lasciandoli liberi di spandersi nel mondo. Ecco, più che catartica, la scrittura mi è sempre parsa un’arte maieutica. Cechov raccontava che prima di iniziare a fare lo scrittore, per molti anni, ha avuto nella sua testa un gruppo sempre più numeroso di personaggi che spingevano per poter venire alla luce, e aveva come la sensazione di doversi sbrigare in fretta, perché molti, col passare del tempo, stavano persino invecchiando. Ecco, quando avverti quel richiamo, quando senti di avere in te qualcosa di inespresso e di inspiegabile, probabilmente è il momento di iniziare a scrivere. Magari provando a descrivere quello che avverti fingendo che l’abbia vissuto qualcun altro. Forse è questa la catarsi? Non lo so. Ma è inutile chiederlo all’inventore del termine, non lo spiega neanche Aristotele, lo dà per presupposto.
Da chi vorresti ricevere una recensione o un consiglio letterario?
Oddio che domandone! Da tantissima gente, mi sembra più che naturale. Però, ecco, se dovessi distinguere, mi sarebbe molto piaciuto essere recensito da qualche semiologo strutturalista, diciamo un Todorov per esempio. La sua Poetica Della Prosa fu un libro fondamentale per comprendere il meccanismo e la codifica di moltissimi procedimenti letterari, il suo sguardo puntuale, asciutto, leggero e profondo sul testo e la testualità restano senza pari per chiunque voglia comprendere i segreti di un romanzo. C’era una canzone di Guccini in cui diceva “ah, se le canzonette me le recensisse Roland Barthes!”. In effetti anche lui non sarebbe affatto male (Barthes, ovviamente, non Guccini). Ricordo le sue mirabili recensioni su le massime di Rochefoucauld, dopo averle lette ti veniva da dire: ma certo, è ovvio, è chiaro che sia così. Ma prima di aver letto Barthes ti sembravano solo un mare di aforismi ineffabili. Riuscire a recensire anche quei testi, ed enuclearne le strutture nascoste è un’impresa non da tutti, quasi un’indagine neurologica. Credo che sarebbe giusto italianizzarne il nome, per il contributo universale e imprescindibile dato al pensiero umano. Del resto, abbiamo italianizzato Cartesio che in realtà si chiamava Descartes. Potremmo chiamarlo Bartesio, lo renderebbe più familiare, come dovrebbe essere. Invece, quanto ai consigli letterari, mah… potrei dire Kundera, oppure King, o magari Dan Brown, e perché no, Grisham. Ma sarebbe inutile, so già che mi mentirebbero. Gli scrittori odiano gli esordienti, come Woody Allen fece dire ad Hemingway nel film Midnight in Paris: se vedo un brutto romanzo lo odio perché non sopporto la brutta prosa, se invece vedo un romanzo bello lo odio perché non l’ho scritto io. Quindi, non confido in aiuti letterari, per quanto li gradirei molto, e cerco di rubare ogni frammento da chiunque, anche da chi mi rivolga critiche o sarcasmi. Forse dovrei fare come suggeriva Borges: fingere che i libri che vorrei scrivere siano già stati scritti, e limitarmi a farne da solo la recensione. Ma forse questa tecnica vale solo per lui, e le sue memorabili Finzioni.
Dalla prospettiva del lettore, invece, come ti definisci e quali libri ci sono attualmente sul suo comodino?
Sono un lettore avido, e curioso. Mi piacciono le sfide, mi piace andare direttamente alle fonti ed evitare le letture di seconda mano, i commentari, le biografie, le storiografie, le antologie. Leggo sia romanzi che saggistica. Cerco di nutrire entrambi gli emisferi della mia corteccia. Tra i saggi, sulla scrivania ho una pila composta principalmente da semiologi: c’è Paolo Fabbri, c’è Todorov, c’è Aristotele (la retorica e la poetica), c’è Umberto Eco. Ma anche Odifreddi. Per esempio, ho scritto una recensione ad un suo trattato sulla logica per il mio blog e ho notato alcuni giorni dopo che lui l’aveva postato sul suo sito. Che paradosso: invece di aver fatto pubblicità io a lui, l’ha fatta lui a me; e naturalmente mi ha fatto anche molto piacere. Tra i romanzi, ho alcune predilezioni territoriali, come i russi, per esempio. Sto completando i romanzi di Dostoevsky e Tolstoj, ne leggo uno all’anno di ciascuno dei due, attualmente sto su Guerra e Pace. E poi ho gialli storici, quelli della collana Enigma, Manfredi, tantissimo Kundera, e Cechov, Gogol i cui racconti trovo irresistibili. E poi i portoghesi, come Saramago e Pessoa, maestri di dialettica e di fantasia. E poi gli americani: Faulkner, Philip Roth, Hemingway, Bukowski e Foster Wallace. Per esempio, nella stessa colonnina, subito sotto Guerra e Pace c’è Infinite Jest. Però, ad essere sincero, i libri troppo lunghi li spezzetto, talvolta li abbandono per mesi, e poi ritorno e li finisco. Ma nel frattempo ho troppa curiosità di leggere anche altro. Diciamo che se il libro si mantiene entro le 600, massimo 700 pagine, ed è un romanzo, allora è molto difficile interromperlo, riesco ad entrare meglio in sintonia, e al massimo in una settimana, o dieci giorni, riesco a concluderlo. Se invece è più lungo, e ha un respiro mensile, devo per forza interromperlo, ho la necessità di cambiare ritmo e non rimanere troppo a lungo su uno stesso testo.
Hai già in cantiere un secondo progetto letterario? Se sì, dobbiamo aspettarci lo stesso genere o qualcosa di diverso?
Sì, ho già scritto quasi metà di un nuovo romanzo. Ed è un genere un po’ diverso. Anche se mantiene in comune con il precedente la volontà di voler abbattere le tradizionali categorie di genere. E quindi, da questo punto di vista si trova in buona compagnia col primogenito. Il romanzo secondo qualcuno sarebbe morto con la nascita della letteratura di consumo, perché la fantasia dell’autore sarebbe stata piegata alle esigenze editoriali. E in effetti gli editori, per non rischiare, tendono a rendere le pubblicazioni semplicemente dei contenuti da riempire per impostare investimenti economici puntando sull’usato sicuro, piuttosto che sull’audace novità. È accaduto per la letteratura quello che in qualche modo era accaduto per molte altre forme d’arte: è scomparsa la musica classica, l’artista tende a creare opere di compromesso tra la propria ispirazione estetica e un presumibile gradimento del pubblico cui si rivolge l’opera. Per me scrivere romanzi significa slegarmi da un’idea di utilità, o di ricerca di consenso. Scrivo per provocare, per deformare, per sperimentare, per capire, per capirmi, per ricordare, per dimenticare. Per contraddire e per contraddirmi. Tanto, nessuno è mai morto di paradossi. Diderot ci ha insegnato che un romanzo può avere tantissime modalità di espressione, e Borges le ha anticipate quasi tutte nei suoi racconti. Anzi, ha persino anticipato forme di romanzo che devono ancora essere pensate, come Humpty Dumpty faceva con le poesie di Alice. Noi tutti siamo Alice, ovvio, e viviamo in un universo Carroll-iano. Però, chissà perché, la nostra fantasia letteraria è rimasta ancora legata all’epopea dell’eroe e del recupero della quiete infranta. Mentre ci sono molti modi per sospendere l’incredulità. Ad ogni modo ho già le idee chiare per il terzo romanzo, e ho voglia di parlarne. Sarà il racconto epistolare apocrifo di una fanciulla avvelenata da un magnate delle telecomunicazioni perché non rivelasse i nomi dei programmatori informatici assassinati per impedire la conoscenza dei social network che avevano inventato. Descrivendo nel dettaglio tutte le loro caratteristiche, le funzionalità, i nomi e i cognomi dei programmi e degli autori, dei mandanti e dei mandatari. Ma non dovrebbe essere un romanzo di fantascienza: vorrei tradurlo in inglese e farlo spedire per posta dall’America a qualche procuratore italiano in cerca di notorietà, affinché avvii un’indagine contro ignoti, e poi contro di me, una volta compreso lo scherzo che gli avevo giocato. Abbiamo conosciuto processi intentati per molto meno, quindi, con qualche carta bollata, e qualche errore ortografico messo al posto giusto, potrei riuscirci. Il mio modello sarebbero i ragazzi dei falsi Modigliani degli anni ottanta. Il massimo sarebbe se venissi processato, e magari arrestato per procurato allarme, o per calunnia, o per lesa maestà, o per qualsiasi altra cosa. Immagina, che pubblicità ne verrebbe fuori: sarebbe un caso letterario formidabile. Certo, so cosa stai per chiedermi: ma a questo punto, dove sarebbe il confine tra il romanzo e la sua promozione? Non l’ho ancora deciso, lo farò a suo tempo. Però, ecco, questo vorrei vedere in uno scrittore, oggi; e questo, invece, dispero di trovare. Non ci sono più le avanguardie, perché i romanzieri non si fanno più arrestare: si fermano prima.