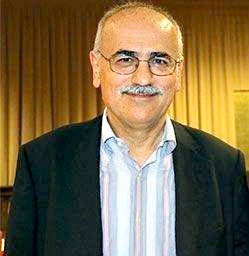Dr. Davide Pagnoncelli: Scuola, il luogo per eccellenza di compartecipazione emotiva e di sviluppo dell’intelligenza sociale
“La scuola è il luogo per eccellenza di compartecipazione emotiva e di sviluppo dell’intelligenza sociale”, ce lo spiega il Dottor Davide Pagnoncelli.
Sintesi delle relazioni tenute in occasione dell’audizione del 1 ottobre 2019 presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e dell’audizione del 1 luglio 2020 presso le Commissioni riunite della Giustizia e degli Affari Costituzionale del Senato.
Le varie audizioni di esperti o professionisti sono state programmate in merito alla discussione di un Disegno di legge contro il bullismo e il cyberbullismo.
Da venti anni – afferma lo psicologo e psicoterapeuta Davide Pagnoncelli – sono responsabile, presso le scuole dell’Opera S. Alessandro di Bergamo, di un Servizio Psicologico scolastico, unico nel suo genere, che garantisce continuità di intervento dall’inizio di settembre alla fine di giugno di ogni anno scolastico. Il mio intervento come psicologo si articola in tre direzioni: alunni, genitori e personale scolastico, con presenza ogni settimana in quattro scuole, dalla Primaria alla Secondaria, sia di primo che di secondo grado.
Gli alunni di cui mi sono occupato e di cui mi occupo sanno molto bene che quando si costruisce un piano di una casa, pur bellissimo, occorre che sia inserito in una struttura portante precisa e che deve essere collegato al resto della struttura, possibilmente antisismica, cioè molto flessibile in previsione di possibili scosse sismiche. Fuor di metafora, non è certo funzionale che i ragazzi siano coinvolti in ottimi e stupendi progetti, ma con interventi slegati tra loro e in città o paesi non comunicanti. La ricaduta formativa di vari progetti troppo spesso resta circoscritta e non si espande almeno a tutto il territorio nazionale.
In un contesto educativo e formativo servono leggi e progetti che stimolino la connessione con vari ambiti di intervento e le diverse professionalità, servono leggi adattabili ai vari contesti locali e progetti flessibili perché la società e le persone evolvono rapidamente, servono leggi e progetti che sostengano coloro che vivono con passione e con creatività la scelta di educare i giovani e le loro famiglie.
Tutto ciò mettendo al centro la scuola e la famiglia, sollecitando e predisponendo progetti “forti” di prevenzione e di formazione.
I giovani sono il nostro futuro e dobbiamo garantire loro un futuro di qualità. Nessuno può prevedere né ipotecare il futuro, però noi adulti possiamo incanalare verso di esso le energie migliori. La conoscenza umana è sempre comparativa, il presente viene confrontato col passato; altrimenti non è possibile conoscere compiutamente il presente, né progettare al meglio il futuro.
Già nell’antica Grecia il filosofo Eraclito, vissuto tra il VI e il V secolo a.C., affermava che coloro che hanno in comune il logos, hanno in comune il mondo; gli altri hanno in comune il sonno. Diremmo oggi: chi ha in comune il logos (verbum in latino, parola, discorso, pensiero, sapere) ha in comune la consapevolezza condivisa, compartecipata. Lo scetticismo era appunto… scettico sulla possibilità di ri-conoscere qualcosa di comune.
L’uomo è capace di condividere il mondo, di farlo diventare comune. Come? Attraverso il dialogo (dia-logos) perché le parole sono lo specchio del pensiero che le ha generate e diventano qualcosa in comune, diventano comunicazione.
Oggi sui social ognuno può dire facilmente la propria opinione, ma non è facile precisare quanto ci possa essere di con-divisibile e quanto no; numerosissime finestre sono aperte sul mondo, ma sembra ci possa essere poco o niente di originario, di comune, di condivisibile. La nostra società rischia di essere una società senza finalità, al di là della funzionalità e dell’evoluzione tecnologica.
C’è qualcosa per cui val la pena costruire il futuro? Qualcosa che può durare? Se vogliamo essere liberi, non possiamo essere sequestrati e imprigionati nel passato e nel presente, bensì immaginare un futuro diverso e migliore. Soprattutto aperto e facilitatore delle potenzialità di ogni individuo.
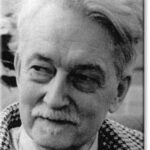
Per il filosofo francese Jacques Maritain (1882-1973) il pluralismo è il contrario del totalitarismo, il pluralismo è capace di riconoscere ciò che è comune, appunto condivisibile. La democrazia -a differenza del relativismo- richiede valori condivisi, richiede la costruzione di un orizzonte condiviso.
L’educazione è importante abbia i connotati della reciprocità, che famiglia, scuola, comunità e individui interagiscano secondo una logica di circolarità formativa e di intervento continuo e permanente. Non è possibile educare senza che ci sia il riconoscimento di qualcosa di comune o che, perlomeno, ci sia la ricerca di ciò che potrebbe esserci di comune. E c’è convivialità solo in coloro che si ri-conoscono e che con-dividono valori comuni.
La scuola è il luogo per eccellenza di convivenza (o dovrebbe esserlo), di convivialità, di compartecipazione emotiva, di sviluppo dell’intelligenza sociale.

Alfred Adler, uno dei padri fondatori della psicologia del profondo assieme a Freud e Jung, ha affermato: “Il sentimento sociale è il barometro della normalità”. Più il sentimento sociale si affievolisce o addirittura sparisce, più le problematiche psicosociali e le patologie psichiche si aggravano.
La scuola è anche il luogo dove si affrontano tutte le emozioni, anche quelle spiacevoli come per es. la paura, e dove si educano i sentimenti; le emozioni sono variabili, fluide, passano; i sentimenti, invece, vanno coltivati con molta cura.
La scuola è il luogo dove ci si può sentire sicuri e accolti, è il posto privilegiato da cui si può guardare il mondo e costruire la propria identità, aumentando l’autostima.
La scuola non è solo conoscenza e fare secondo un modello esclusivamente trasmissivo, ma è anche educazione dell’intelligenza emotiva, stimolo per essere se stessi in modo unico e irripetibile. Perché noi sappiamo più di quello che comprendiamo. D’altronde come noi ricordiamo i nostri insegnanti? Per i “tipi” che erano e per la loro personalità, più che per come insegnavano e per cosa spiegavano.
Informazione, conoscenza, comprensione, saper essere: da tutto ciò deriva la saggezza.
Dalla scuola è essenziale partire per costruire progetti di prevenzione e di formazione. Perché? Per il semplice motivo che la scuola è l’unico posto dove passano tutti, proprio tutti, e tutti ci stanno per molti anni. Diversamente la prevenzione diventa pura illusione, mitologia consolatoria, pura petizione di principio; diversamente l’integrazione, l’inclusione si traducono in sterili fantasie; diversamente, per esempio, la prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e di altri disturbi psicosociali risulterà inefficace, con conseguente spreco di risorse umane e finanziarie.
La scuola è confronto dialogico: al di là dei contenuti, dei programmi e di quant’altro la scuola è essenzialmente relazione, cioè convivenza, condivisione, compartecipazione emotiva. Quello che non è possibile togliere alla scuola è la comunicazione tra persone, comunicazione che struttura relazioni.
Prima dei contenuti, prima delle metodologie, prima della tecnologia, prima di tutto la scuola è relazione!
È importante intervenire non solo con interventi riparativi e rieducativi, ma anche di sostegno alla genitorialità e con progetti ad hoc di tipo psicoeducativo e psicosociale. Il tutto con il coinvolgimento dei servizi sociali del territorio e, io credo, anche di professionisti con esperienza sul campo e con competenza specifica.
È meglio progettare qualcosa di positivo, piuttosto che lottare contro qualcosa di negativo, è più funzionale attuare progetti preventivi piuttosto che combattere qualcosa di problematico che non si è riusciti a bloccare in tempo.
Vanno sviluppati comportamenti prosociali, all’interno dei quali sviluppare concretamente esperienze di sviluppo del sentimento sociale, stimolando la crescita di leader positivi.
Facciamo crescere i ragazzi, non i loro problemi!
Tali progetti di tipo educativo e preventivo è essenziale siano attivati con l’apporto di varie professionalità e tramite percorsi esperienziali (più che con corsi) e con l’utilizzo di metodologie attive, artistiche e creativamente innovative.
Non è più ipotizzabile organizzare interventi “mordi e fuggi” senza un’adeguata continuità temporale e condivisione di specifici follow-up.
Per esperienza so che i giovani più che ascoltare quanto noi adulti diciamo, imitano quanto noi facciamo. I ragazzi ci imitano, anche quando sembra che essi non ci ascoltino, anche quando ci contestano: conta ciò che noi facciamo (o che faremo). D’altronde i valori vengono trasmessi non tanto con le parole, ma con i nostri comportamenti, con il nostro stile di vita.
Perciò possiamo noi adulti offrire un esempio, un modello di riferimento per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva? Le comunità di riferimento può offrire un esempio, un modello di riferimento anche per lo sviluppo dell’intelligenza sociale, del sentimento sociale?
Noi adulti abbiamo bisogno di offrire anche più qualità al tempo dei nostri contatti sociali, delle nostre relazioni con le nuove generazioni.
La felicità non “risiede” negli oggetti o nella tecnologia, ma è correlata alla qualità delle relazioni interpersonali. Dove non c’è buona qualità delle relazioni interpersonali, è molto più facile sorgano vari tipi di problematiche psicosociali e dipendenze, sia che con sostanza che senza sostanza (da web, da cellulare, da gioco d’azzardo patologico).
Una società funzionale si costruisce sulla base di una rete di relazioni interpersonali caratterizzate meno dall’ “io” e maggiormente dal senso del “noi”, della comunità.
Ciò appare importante anche in ambito lavorativo, sportivo o in varie attività di gruppo e, a maggior ragione, in contesti educativi. In caso contrario si verificano legami che non collegano positivamente le persone, relazioni intergenerazionali superficiali, fredde, senza autentica compartecipazione emotiva. Occorre sviluppare con progettazioni puntuali e concrete, non solo con assunti teorici e generici, l’intelligenza emotiva e l’intelligenza sociale.
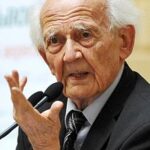
Il sociologo Zygmunt Bauman scomparso nel gennaio del 2017 scriveva: “In questo mondo si chiede agli uomini di cercare soluzioni private a problemi sociali, anziché soluzioni di origine sociale a problemi privati”.
Non bastano iniziative -pur ben realizzate- isolate o slegate dal contesto, servono progetti comunitari, scevri da gelosie sterili e da diritti di primogenitura, da realizzare con modalità non competitive e non narcisistiche, ma con disponibilità alla interconnessione reciproca e alla positiva emulazione. Per ogni problematica serviranno certamente strumenti specifici e opportuna preparazione professionale ed educativa, ma sempre contestualizzata, nel contesto (con-textus), inserita all’interno di un progetto corale.
La malavita è organizzata, si suol dire, la… “benevita” dovrebbe organizzarsi di più e meglio!
La società può investire maggiormente, tramite la scuola, sullo sviluppo dell’intelligenza sociale, sul sentimento sociale, su comunità socialmente intelligenti, altrimenti la società sarà destinata -prima o poi- a deperire, preda di forti spinte conflittuali.
Dott. Davide Pagnoncelli
allargacervelli@gmail.com